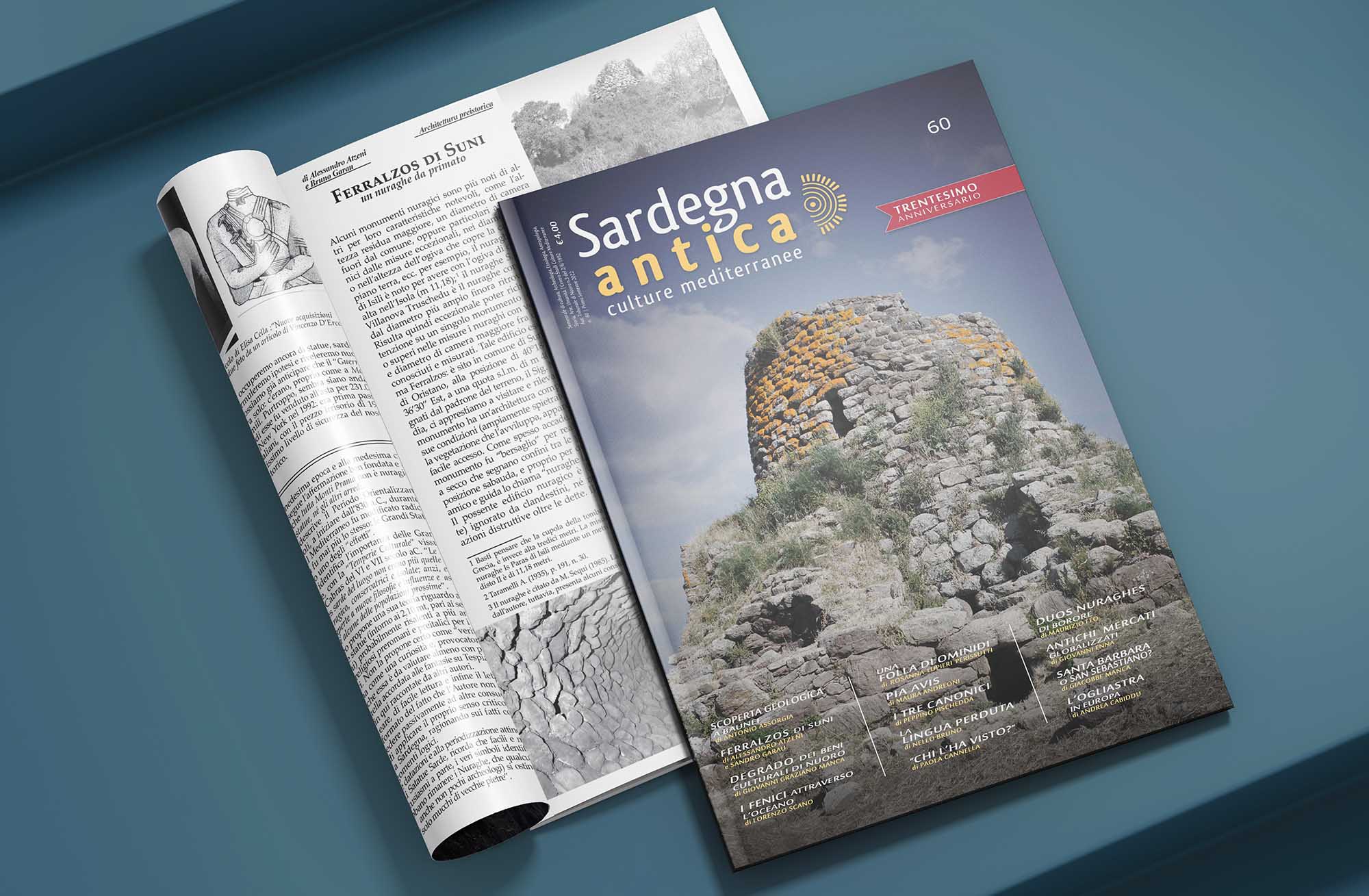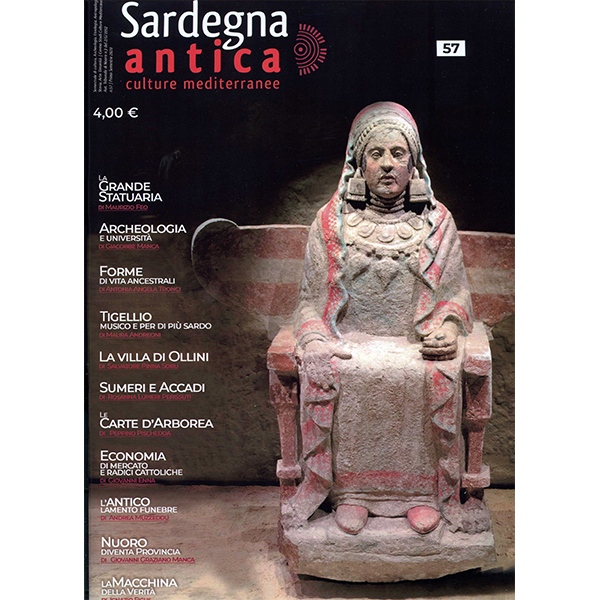Disponibile da Novembre 2022, il nuovo numero 61 di Sardegna Antica
Il numero 61 della Rivista Sardegna Antica, si presenta denso di argomenti intreressanti, che ci sembrano adatti al periodo che stiamo attraversando: si parla infatti di Salute, come anche di Guerra Mondiale, senza dimenticare il nostro costante imperativo, che consiste nella corretta interpretazione della storia della Sardegna. Vediamo una breve rassegna delle ricerche e gli studi proprosti al vostro gradimento.
Per prima, M. Andreoni, con l’articolo Homo Patiens, accoglie egregiamente il lettore, accompagnandolo tra magia, religione e medicina del mondo antico: lo guida sicura tra le acque curative sarde di Fordongianus, attraverso l’Etrusca Disciplina, le pratiche medico-superstiziose greche e latine, fino alla nascita del simbolo del Caduceo, quasi alle soglie della scienza medica. Seguono due articoli di M. Feo, volti a ribadire i validi motivi dell’equidistanza di Sardegna Antica sia dalle imprecisioni dell’Accademia (Pietà religiosa e vanità terrena) su cronologia e interpretazione materiale), sia dalla “Fantarcheologia” di molti non addetti ai lavori (Gil Gamesh. L’eroe e la scrittura) circa l’invenzione della “scrittura nuragica”. A. Assorgia (Il Supramonte di Baunei) descrive e spiega le fascinose meraviglie geologiche, archeologiche e botaniche del Monte di Baunei, rivelandone alcune ignote e proponendo nuove prospettive di ricerca. G. Manca (Danza Nuragica) interviene con un’ulteriore sua critica – sarcastica e umoristica, come d’uso, ma sempre didattica e ben argomentata – verso l’atteggiamento superficiale e inconcludente dell’Accademia sarda nei confronti della civiltà nativa, cui restano dunque scarse possibilità d’essere compresa e conosciuta.
A. Atzeni (La prima alabarda in Sardegna) ci offre un sintetico, ma veramente ottimo esempio di archeologia interpretativa, dimostrando che essa è possibile anche in Sardegna: una fresca ventata di benvenuta razionalità, fonte di ottimismo.
Seguono due articoli d’argomento bellico, visti i tempi attuali: il primo è di G. Enna (La Grande Guerra e l’epopea della Brigata Sassari), che rievoca anche da un punto di vista sardo, rilevanti fatti storici, economici e di costume, che prepararono, accompagnarono e seguirono alla Grande Guerra; il secondo è di P. Pischedda (I Dimonios e Raimondo Scintu), che fa rivivere l’Eroe Scintu, la Brigata Sassari e aneddoti poco noti di valore, dedizione ed eroismo isolano. Insieme, i due articoli compongono un unico racconto in cui sembra d’intravvedere – per un momento – il genio di Emilio Lussu, che firmò un terribile diario resoconto (l’unico esistente!) della Prima Guerra Mondiale.
Quindi C. Maccioni (Il Fuoco. Francesco Ciusa e Sebastiano Satta) espone un ben documentato studio, veramente interessante e pieno di riferimenti, nel quale svela un parallelo tanto artistico, quanto profondamente umano tra i due amici e artisti nuoresi, partendo da un bassorilievo donato dal Ciusa al Satta e accompagnando quest’ultimo – il più anziano – oltre la prematura scomparsa per malattia, fino al monumento funebre dedicatogli dall’amico scultore.
Giovanni Graziano Manca (Marcello Serra nel cinema documentario sardo) descrive il Serra come un sardo che voleva far conoscere l’amata terra al vasto pubblico televisivo. Spiega che il suo modo di documentare l’isola come un luogo magico, forse mentiva un poco (certamente non quanto si mente oggi in costosissimi filmati infondati!), quasi mostrandosi in attesa di un fulgido futuro che, purtroppo, ancora non è arrivato.
Infine Nello Bruno (Su Irgu Marras) spiega, per gli amanti delle lingue e dell’etimologia, la derivazione forse semitica di una definizione dialettale sarda per un fenomeno naturale come i lampi a ciel sereno. A quanto pare la spiegazione passerebbe per quel simpatico e raro mammifero marino noto come “bue marino”, la foca monaca: altrimenti, la denominazione dialettale non troverebbe una plausibile spiegazione. Completa le pagine di questo numero la citazione di tre libri interessanti: uno è “Sorprendenti piante del Friuli” (di S. Costantini e A. Moro), un altro riguarda le “Statue di Mont’e Prama” (di P. Secci) e un terzo “1802, La rivoluzione che non ci fu” (di G. e A. Muzzeddu).
Si segnala che le opinioni espresse nelle relative recensioni sono valutazioni personali e che certo non avremmo perso tempo con analisi di libri che non meritano menzione. Infine, a proposito di libri, è forse il caso di annunciare l’imminente edizione di uno nuovo dell’archeologo G. Manca, che è tanto poco atteso quanto sarà sorprendente: “Archeologia dell’Isola Selvaggia: from an original idea by Duncan Mackenzie”, di cui si mostra la copertina. Il titolo bilingue allude al fatto che si tratta di un’affidabile traduzione – commentata e spiegata da Manca – dall’originale inglese dei testi dell’archeologo scozzese, inviato in Sardegna dalla British School of Rome. Lo stesso che Arthur Evans aveva scelto come compagno per scavare a Cnosso. Nel nuovo libro di Manca si descrivono gli eventi, talvolta contorti e complessi, che impedirono una pronta traduzione e divulgazione degli scritti originali. Si sottolineano gli errori in cui incappò lo scozzese, solo apparentemente bene accolto dagli archeologi sardi coevi. Si racconta come avvenne che tali errori di valutazione architettonica furono presi per veritieri in accademia e riproposti pedissequamente, senza alcun senso critico, né dubbi in altri testi.
Insomma, non è solo un libro di archeologia sarda: è anche – e soprattutto – un resoconto di storia dell’archeologia sarda degli ultimi anni, così come può legittimamente raccontarla chi quegli anni ha vissuto in prima persona. La veste grafica è curata da un ottimo tecnico di scuola moderna e richiama i contenuti attraverso gli schemi dei monumenti analizzati. Nel retro copertina è il ritratto di Mackenzie è reso con una tecnica elettronica attraverso i suoi stessi scritti inglesi. Il CSCM e la Grafica del Parteolla sono certi che l’opera sarà rivoluzionaria per l’Archeologia sarda.
Un libro che non prenderà polvere su uno scaffale…
Sommario
- Homo patiens – Maura Andreoni
- Pietà Religiosa e Vanità Terrena – Maurizio Feo
- Ghilgaméš. L’eroe e la scrittura – Maurizio Feo
- Il Supramonte di Baunei, nuove scoperte – Antonio Assorgia
- Danza Nuragica – Giacobbe Manca
- La prima alabarda preistorica in Sardegna – Alessandro Atzeni
- La Grande Guerra e l’epopea della Brigata Sassari – Giovanni Enna
- I Dimonios e Raimondo Scintu – Peppino Pischedda
- Il Fuoco: Francesco Ciusa e Sebastiano Satta – Carlo Maccioni
- Marcello Serra e il cinema documentario sardo – Giovanni Graziano Manca
- Su Irgu marras- Nello Bruno
IL NUOVO NUMERO IN EDICOLA