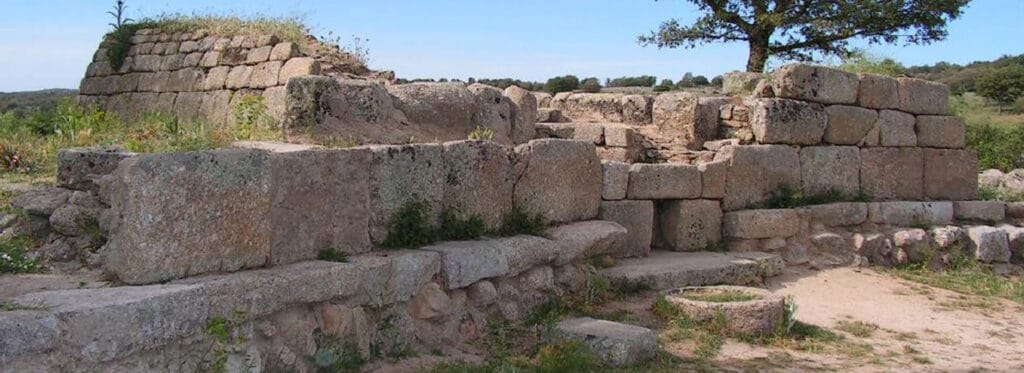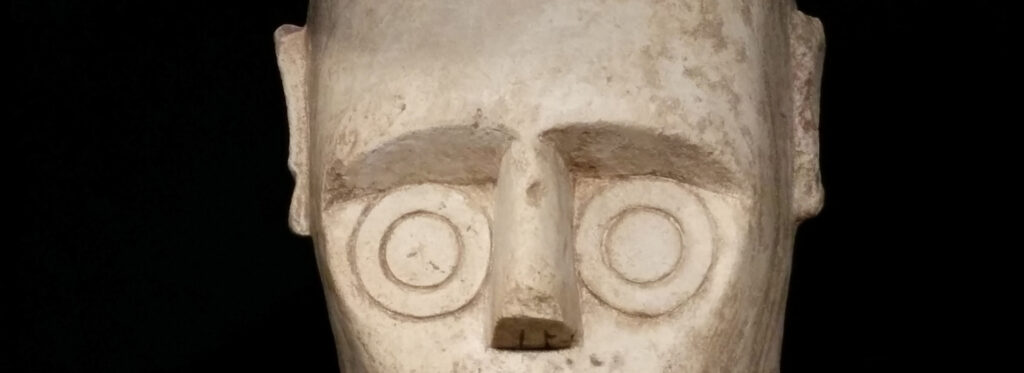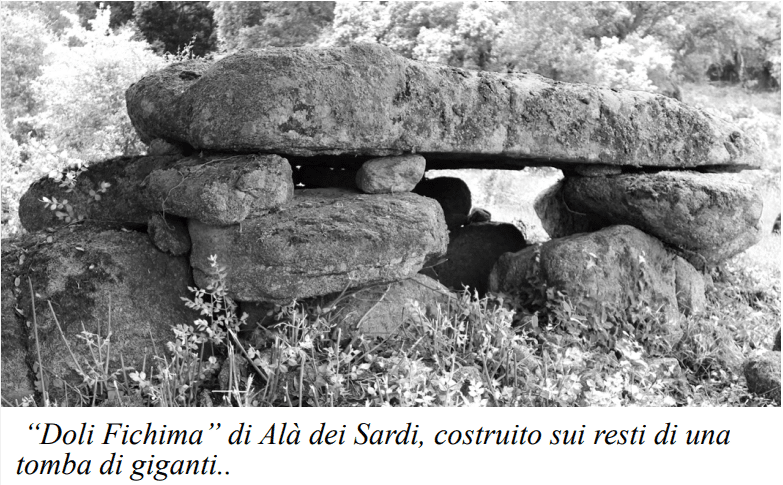Il Numero 58 della Rivista tratta finalmente un argomento a lungo sollecitato dai lettori di Sardegna Antica. Mira a un bersaglio molto ambito: un aggiornato chiarimento didattico-scientifico sulle statue di Monti Prama, cui si giunge dopo una “preparazione” sviluppata nei due numeri precedenti. Sarà – crediamo, immodestamente – un numero da collezione, unico e irripetibile, nel quale le Grandi Statue Sarde sono un argomento di gran peso, in tutti i sensi. Ad onta della sintesi, non tutto il ponderoso argomento ha potuto trovare posto in un unico numero. Alcune imprescindibili considerazioni conclusive seguiranno nel fascicolo n. 59.
Molte ipotesi popolari, false e strumentali, imprecise o favolistiche, troveranno definitiva confutazione in queste pagine, seppure esse fossero mai state credute vere in passato. Come sempre, ogni autore si assume la responsabilità culturale di ciò che afferma. Le argomentazioni proposte ci sembrano convincenti, e già questo sarà un merito: perché se, da una parte, è inaccettabile che Scienza e Storia siano piegate a interessi politici e/o commerciali, d’altra parte non si deve permettere che un tema culturale di vero interesse mondiale sia ridotto a strumento tanto provinciale e identitario da scadere in discussioni dai toni accesi e incongrui, coi tipici, rozzi modi dell’ignoranza più ingovernabile e sanguigna. I nodi culturali e cronologici, d’antica origine, sono personali dei singoli autori, come già detto.
Ci è sembrato giusto ripubblicare qui l’articolo originale, in Campidanese, con cui Giuanni Lilliu comunicò, nel 1983, per la prima volta in termini divulgativi, sia la scoperta delle statue sia i suoi significati “ufficiali”. Vale la pena perché del fascicolo, è giusto notare, si vendettero tante copie, ma non moltissime. [Per i pochi che non hanno consuetudine col sardo, la traduzione in Italiano è qui proposta, a fronte, a cura di G. Manca].
“Sardigna Antiga”, in origine, oggi Sardegna Antica C.M., nell’occasione dedicò alle Statue la copertina, che ricompare in queste pagine. ¿Troverà motivo di “pace” chi ancora sostiene un generale e voluto occultamento? Tuttavia, ¡resta pur vero che ci furono lunghi anni di attesa, tentennamenti e disguidi! Quel ritardo, semplicemente chiosa ed esemplifica le grandi difficoltà – non economiche! – in cui si dibatte tutta l’archeologia italiana e specialmente quella sarda, da tempo agonizzante.
Un inedito articolo di C. Tronchetti chiarirà persino ai non addetti ai lavori il motivo per cui noi riteniamo che egli sia da considerarsi “il vero scavatore” di Monti Prama. Altro è dire della misura in cui ciascuno è disponibile a condividere la collocazione culturale in un ancora seguito Nuragico lilliano, sospetto per longevità. Certamente lo scritto, di prima mano, sarà gradito anche agli esperti veri.
Un punto di vista personale, da parte di chi visse in prima fila quegli anni e quell’ambiente, sarà offerto da L. Scano, che poi si adoperò, col compianto Francesco Nicosia, già Soprintendente di Sassari, per dare una svolta al crescente malcontento. Lo Scano diede una spallata politico-economica e fece riemergere le statue dagli scantinati restituendoli allo studio e al mondo.
I risultati del pessimo restauro non sono certo a lui imputabili, quanto a chi fu incaricata di sorvegliare appalti e operazioni di restauro… e non lo seppe fare.
M. Feo proporrà un originale inquadramento classificatorio del fenomeno di Monti Prama, a conclusione dei due precedenti, fondamentali articoli, comparsi nei fascicoli 56 e 57, preparatori al presente.
In questo numero trovano continuità o compimento la riflessione “Archeologia e università” (maiuscolo e minuscolo intenzionali), di G. Manca e l’argomento geologico e paleontologico di A.A. Tronci. Altri temi d’interesse sono “Il culto dei morti” di G. Enna e la ricerca di Andrea Muzzeddu, sulla persistenza di riti antichi nelle prassi funerarie moderne.
Segnaliamo, per la penna di N. Bruno, l’assoluta novità di “Linguistica storica”: una critica distaccata, foriera di una stimolante proposta che darà vigore alla tormentata linguistica isolana.
Un’antica, multiforme divinità è richiamata nella recente ricerca su Giove Dolicheno della nostra M. Andreoni, affiancata dala studiosa F. Vecchi.
L’articolo di R. Lupieri Perissutti ci offre una ricca e aggiornata sintesi dell’evoluzione “per tappe rivoluzionarie”del genere umano, dalle australipitecine fino al Sapiens odierno.
Singolare è lo scritto scientifico di M. Fregoni, “Silvestrone sardo”, che dà notizia di un primato mondiale in Sardegna, toccato da un’insospettata essenza vegetale. M. Fregoni ci affida, con scienza specialistica, la meraviglia e il sorriso: ottimo viatico per la speranza anche in queste fasi travagliate.
Si chiude l’elenco delle opere e dei collaboratori per questo numero, indubbiamente speciale, rimandando i lettori anche all’unica breve recensione, di un libro particolare per il suo messaggio umano e affettivo.
È inutile elencare le difficoltà d’ogni genere affrontate (Archivi bloccati, Musei chiusi, Fonti e contatti indisponibili, impossibilità di fare ricerche sul campo, economia languente e seri problemi di salute di alcuni autori), che affliggono anche la Redazione, in questo infinito periodo di crisi sanitaria, economica e politica.
Valga per tutto solo notare il rammarico espresso alla redazione da C. Tronchetti per non potere accedere al migliore materiale fotografico, che avrebbe voluto accludere al suo scritto inedito.
Malgrado tutto, non s’interrompe la pubblicazione di queste nostre sudate e amate pagine, che – dalla provincia più interna della Sardegna – idealmente vogliono abbracciare unitamente i lettori, la cultura sarda e quelle mediterranee.