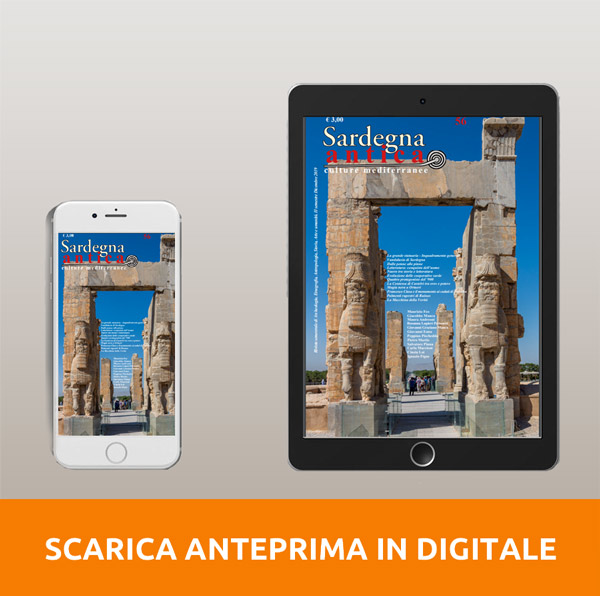Vandalusia di Sardegna
Vandali storici e Vandali odierni
Dei Vandali storici sappiamo molte cose: partirono dal regno fondato in Africa guidati dal re Genserico nel 455 d.C., si stanziarono in Sardegna per proseguire verso Roma, decadente capitale imperiale, che saccheggiarono nello stesso 455.
Erano Germani, provenivano dalle rive del Baltico (tra l’Oder e la Vistola), quindi si spostarono in Pannonia (409) per poi invadere la Gallia e la Spagna (La Vandalusia , oggi Andalusia).
Passato lo stretto di Gibilterra (428), si fusero con gli Alani (erano Irani o Ariani), divenendo potenti al comando di Genserico.
Il loro regno si estendeva lungo l’ex provincia romana dell’Africa mediterranea, da Gibilterra alla Cirenaica (attuali Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, cui presto di aggiunsero la Sicilia, le Baleari e la Sardegna).
In quest’Isola misero piede nel 455 quando, sempre al comando di Genserico, volsero le prue verso Roma (455), che fu saccheggiata.
Volendo dare credibilità a certe raffigurazioni pittoriche del “sacco di Roma” vandalico, si dovrebbe credere – senza prova – che allora fu trafugata la menorah aurea, tenuta a Roma dopo la distruzione del tempio a Gerusalemme
Imperversarono in Sardegna per circa 80 anni, fino alla sconfitta subita dai Bizantini nel 534.
Nessun monumento di rilievo restò nell’Isola dalla loro azione di rude spoliazione, ma è indubitabile che anche loro seppellissero i defunti con una modalità che da diversi anni tende a delinearsi attraverso tombe dalle caratteristiche assai essenziali e, in modo analogo – è verosimile – seppellirono i depredati isolani, superstiti della Roma famelica.
Il loro nome, tutti sanno, ha l’accezione di incolti, rozzi e violenti, quali furono. Seguivano, però, la dottrina cristiana, secondo i dettami dell’Eresia Ariana.
Significativa la novella di L. Pirandello, dove l’umorismo e il sarcasmo della vita cade su un docente erudito. Assai miope, costui tenne una memorabile Letio Magistralis avverso l’Eresia Ariana, nella sua aula sempre deserta, ma il giorno, per l’irresistibile richiamo della detestata e “oscura” eresia, era invece gremitissima … di soprabiti lì posati casualmente, in un giorno di forte pioggia (in Novelle per un anno, (1937e 1938), postuma).
Veri Vandali e loro emuli odierni, per incultura e genetica, hanno sempre parassitato la società civile.
L’archeologia, nel suo piccolo, ne “parla”, lamentando cicatrici quali esiti di malefatte segnalate, con pervicace cadenza, nelle pagine di Sardegna Antica C. M..
Da tempo però si dà anche conto di rinvenimenti o rivisitazioni su certi monumenti dalla “strana” consistenza, collocabili tra il “ciclopico e l’approssimativo”; essi figurano già nella fantasiosa, “obbligatoria”, letteratura universitaria del dopoguerra, i cui autori “attinsero” in modo discreto (= s’appropriarono in silenzio) – serpeggia la certezza, di certe pubblicazioni del primo Novecento, (una in italiano e tre in inglese), dell’archeologo Duncan Mackenzie, scozzese di buon scotch.
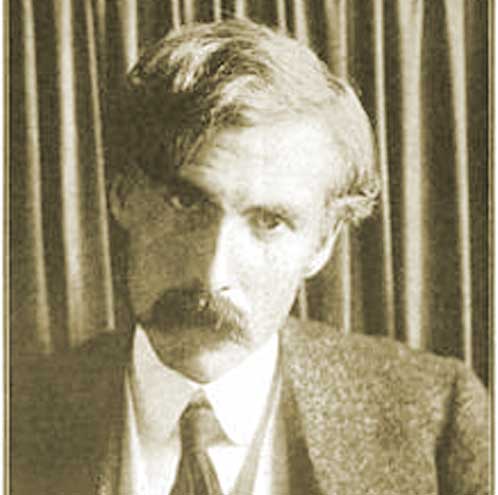
Di D. Mackenzie si conosceva una breve pubblicazione della rivista usonia del 1908, tradotta in italiano dal direttore della British School di Roma, utilizzata come biglietto da visita per fare cassa (convogliata a Londra) per la loro attività di “esplorazione” (periodo coloniale).
Altre tre pubblicazioni erano in inglese e qualche docente se le fece tradurre (fino all’8 settembre del ‘44 si masticava il tedesco). Alla ripresa univer- sitaria, uno scritto del 1910 fu ritenuto particolarmente “fruttuoso” per gli accademici cooptati del secondo dopoguerra, dopo le distruzioni belliche, il vuoto culturale e lo sgomento lasciato dalle leggi razziali, pure acclamate da neo docenti universitari che s’avvantaggiarono della situazione.
Comunque Mackenzie morì nel ‘35; in Sardegna non lo conosceva nessuno e all’università dei miei tempi i docenti si guardarono bene dal consigliarci o procurarci le sue letture: neanche era citato alle lezioni. Era “pascolo riservato” come le fanciulle… “riservate al sovrano”. Ora è tutto più chiaro
Definito “allievo” della British Scool di Roma, in quel momento storico aveva molti motivi per affermare le sue riflessioni: quelle stesse che artigli “padroni”, ingordi, presero dai suoi scritti, in mancanza di studi personali. Presero le sue inferenze e i buoni schemi, per lui realizzati dall’architetto Newton.
Quei disegni sono ancora utilizzati, per cronica mancanza di nuovi apporti (ché gli archeologi indigeni non sanno rilevare i monumenti, né disegnarli e… manco li conoscono).
C’è da dire che i non pochi errori di Mackenzie derivavano dall’inesperienza con i monumenti dell’Isola selvaggia (peraltro, malgrado i trattatelli onirici e gli scritti “autorevoli” di molti, tra Ottocento e Novecento, nessun accademico li conosceva, proprio come accade oggi.
I monumenti dell’Isola “sconosciuta” hanno varietà e particolarità che egli non poteva immaginare malgrado i suoi scavi, a Filacopi, e prima ancora, con A. Evans nell’Egeo, a Micene e a Cnosso.
Dunque Mackenzie ha molte scusanti per gli svarioni delle sue esegesi, magari un po’ meno per i granitici preconcetti mutanti, che lo indirizzavano tra uno scritto e l’altro.
In concreto egli descrisse anche alcuni monumenti culturalmente “intermedi” – secondo lui – tra dolmen e domo de janas, tra dolmen e tombe di giganti, ma diede anche saggi di lettura su alcuni nuraghe.
Quasi tutto ormai fa parte integrante dei manuali universitari detti, ma non alla di lui gloria e memoria, ma d’altri nomi che hanno fatto epoca e che pensavano anche di meritare le medagliette di carta che andavano appiccicandosi al petto (¡l’archeologia era roba di quei Mazzarò! Avrebbe convenuto Verga).
È meglio chiarire che il lesto-prestito, omertoso, non di vantaggio si rivelerà, ma – alla lunga – sarà per loro di grande e disonorevole svantaggio.

Fra i detti monumenti figurano – per i prof attuali – una dozzina di dolmen e come tali da loro collocati nel Neolitico: a ben vederli sono apprestamenti essenziali, senz’arte, fatti con pietre brute e di recupero, spesso gravanti su monumenti ben più antichi che, di per sé, se saputi leggere, offrono riferimenti di cronologia relativa, quantomeno, e comunque allontanano dalle sirene del Neolitico
Per l’archeologia, ben si comprende, le sepolture sono molto importanti, non solo per le civiltà più ricche, ma anche per le culture (= popolo, in Antropologia) più essenziali.
Testimonianze architettoniche (o tipo tombale) o scrigni di ritualità e talvolta di contenuti religiosi, sono testimonianza di chi le produsse. Questo vale anche per i Vandali, che in Sardegna null’altro – parrebbe – abbiano lasciato di sé e della loro violenta società di cavalieri transumanti e grassatori; nell’Isola queste tombe, riconosciute ancora da pochissimi, furono e sono ritenute “dolmen neolitici”, nientemeno, a segno di una sostanziale incapacità di “leggere” le architetture e le loro tecniche costruttive.
L’errore, non da poco, è triplice: limiti nell’approccio conoscitivo in architettura preistorica; limiti culturali; solenne strafalcione cronologico (¡4000 anni di deriva!).
[……..continua………..]
- Biru ‘e Concas (Sorgono)
- 2. ¡Vandali di Stato, per esempio! – grotta Pirosu o Su Benatzu (Santadi)
- 3. L’ultima dei Vandali – S’Ena ‘e sa Vacca (Olzai )
- 4. Vandali e “vandalate”di casa nostra – Monte Baranta (Olmedo)
- 5. Da Biru ‘e Concas a Monte de S’Abe

Leggi l’articolo completo sulla rivista
Vandalusia di Sardegna Leggi tutto »