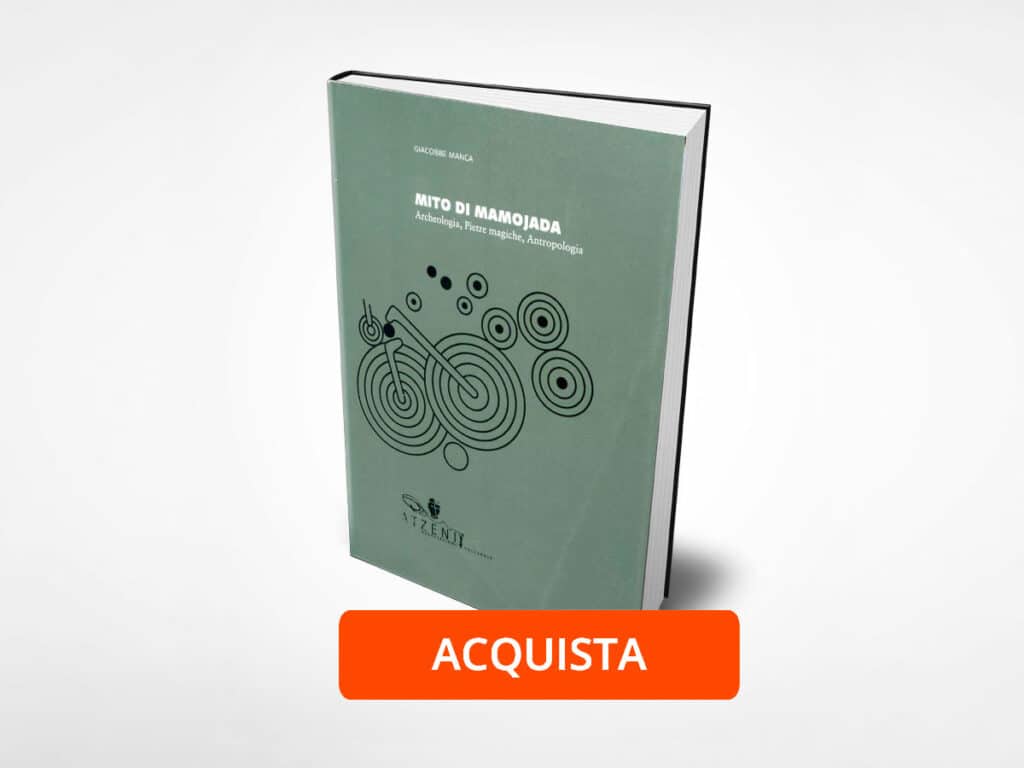Torri del silenzio
Finora è stato visto come sia particolarmente difficile – e spesso impossibile – ricostruire, con i soli strumenti dell’archeologia, le pratiche rituali e il pensiero filosofico-religioso, dei diversi popoli antichi, di cui non sono giunte tradizioni.
Non per giungere ad una verità, ma solo per individuare ipotesi plausibili riconducibili alla ricerca paletnologica, è opportuno rivolgersi alle diverse fonti dell’Antropologia.
Analogamente, il problema dell’interpretazione o della collocazione culturale, si pone anche per quei monumenti “nuovi”, insoliti e persino unici, che fortunatamente si possono ancora rinvenire, come l’allineamento di Ittiri oggetto di queste riflessioni.
Come detto nella prima parte, l’interpretazione quale raro “luogo del silenzio” del ben vistoso, ma finora inosservato, monumento a grossi poliedri ortostati di Sa Figu parrebbe trovare un forte sostegno nella realtà attuale dei Parsi, un’antica popolazione residente tra la Persia e l’India, dove s’insediò a seguito dell’avanzare dell’islam nel loro territorio d’origine.

Il nome “Parsi” deriva da Persi o Persiani e li individua come i discendenti di quell’antico e ben noto popolo del Vicino Oriente, la cui religione improntata al culto di Mitra (Mitra era il Sole e il fuoco), mostra ampie convergenze con i contenuti della mistica di Zarathustra (Zoroastro per i Greci) che si esprime nel culto alla sacralità degli elementi costituenti la Natura.
La componente messianica di questa religione finì anche per avere marcate ascendenze in una larga parte del popolo ebraico nella fase in cui fu deportato nella Babilonia di Nabuchadrezzar (o Nabucodonosor), (dal 586 al 538 a.C.), ma certo anche dalla lunga dominazione Assira (dal 538 al 332 a.C.).

Da quell’influsso, presente in un’importante componente dell’ebraismo, quella messianica della grande fucina mistica di Qumram, presso il Mar Morto, si avranno sensibili conseguenze nella predicazione cristiana. Analogamente, particolari contenuti della religione mitraica avranno esplicite e sorprendenti convergenze contenutistiche nella teologia cristiana.
Attestato estesamente in antico, il rito della scarnificazione – nelle sue diversificazioni potrebbe sembrare un fatto lontanissimo dalle consuetudini del terzo millennio e, ove sopravvivesse ancora, una pratica sconveniente di anacroni stici gruppuscoli, ancora agganciati alla preistoria.
La potente, chiusa ma moderna etnia dei Parsi vive a Bombay, dove ha una florida condizione economica basata su tecnologie avanzate. Detengono ampie aree boscate dove praticano la loro singolare prassi funeraria, secondo il loro credo religioso, il cui fondamentale imperativo è il rispetto della purezza degli elementi divini Terra, Fuoco, Aria e Acqua, quali fattori fondamentali della Natura e della vita.
Per questo la dissoluzione dei cadaveri non deve contaminare alcuno di questi componenti. La soluzione coerente è che i corpi dei defunti siano esposti alla solerzia dei numerosi avvoltoi – oggi allevati di proposito(4) , i quali per antichissima consuetudine sono richiamati ai bordi delle mura d’alte torri circolari.
Le dachmars, in occidente definite “torri del silenzio”, sono costruite al culmine di un’altura, e consistono sostanzialmente in un recinto lastricato, chiuso con pareti tali da impedire la vista di una così greve manifestazione, durante la quale, con una ben nota celerità determinata in concreto dal consistente numero di rapaci (meglio se oltre cento), le parti molli del defunto e non poche ossa minori ritornano direttamente a far parte del ciclo biologico della Natura, nel pieno rispetto della sua regola e della sua “purezza divina”.

La collocazione in una dimora definitiva delle ossa avanzate avverrà in cimiteri preposti, dove tutti i componenti del gruppo umano si ricongiungono ai propri antenati e dove, i vivi abbiano un luogo dove “incontrare” e compiangere i defunti.
Immaginando anche contesti diversi e molto più lontani nel tempo, si può anche ipotizzare che non tutte le ossa fossero restituite dal frenetico e rissoso banchetto tenuto dagli avvoltoi e da altri rapaci, giacché è noto che alcune varietà di essi inghiottono le più piccole o spezzano le più grosse facendole cadere sulle rocce, per poi attingere al midollo o agli stessi frantumi.
É da credere che da un tale trattamento avanzino il cranio – se pure veniva esposto e non prelevato in precedenza per riservargli un rito specifico ,(5)
le ossa lunghe più pesanti, come i femori e le placche del bacino, oltre a parti della colonna vertebrale e molte costole…
Giacobbe Manca
L’articolo nel numero 32 – Acquista il fascicolo

Torri del silenzio Leggi tutto »